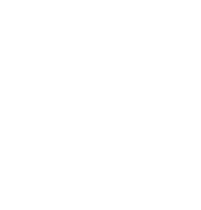Articoli e recensioni.
Siamo quello che mangiamo sosteneva Feuerbach un po’ di tempo fa. Ma non erano tempi bulimici, i suoi, il problema della sussistenza superava di gran lunga ogni istanza teoretica e speculativa. Era il 1862, e lui aveva la vista lunga. Non abbastanza per immaginare che la modernità non solo non avrebbe risolto l’ esiziale questione di come non morire di fame, ma avrebbe trascinato una parte del globo – quella sazia, per una bizzarra nemesi -, in una sorta di coazione a ripetere alimentare e soprattutto visiva. Il cibo ai tempi dei social ha una sua declinazione particolare. Compulsivo il bisogno/desiderio di condividere pietanze a tal punto che il foodporn è una delle tante nevrosi collettive da cui è difficili essere immuni. Siamo quello che vediamo e consumiamo con lo sguardo, anche, esperendo una sorta di narcisismo all’ incontrario dove ci si identifica con il piatto immortalato, e chissà poi se l’ estetica è anche un’etica. E oltre che bello è anche buono.
Questa mostra allora si inserisce in modo chiaro e preciso nella contemporaneità dei temi sociali in cui l’arte fotografica si chiude in se stessa, per dare nuove significazioni all’ oggetto cibo, così democratico e alla portata di tutti, grazie ad uno smartphone. Già, ma come? La posta in gioco non è la retorica di ogni palinsesto che mette la cucina e i suoi derivati al centro di ogni salotto domestico. Forse la risposta abita il nome di questa mostra. Ambrosia, nettare divino e al tempo stesso allucinogeno. Come se l’ ubriacatura di senso, di significato fosse un rischio che non si può non correre se si parla di immagini. E allora il parlarne diventa un dialogo intimo e personale che il fotografo inaugura con le proprie proiezioni. Il nutrimento ritratto è fatto di carne e di anima, di un sentire che porta ciascuno degli artisti a scannerizzare dentro di sé la percezione di ciò che lo alimenta. Un “madamina il catalogo è questo” di una privata galleria di sguardi interpretata con suggestioni diverse, dove un colore diventa il la per una polisemia di cibi uniti da tonalità cromatiche simili come nel caso di Guido Cecere, la presenza scenica di una bottiglia di vino appoggiata su un nudo femminile tratteggia lo stile di Maurizio Melozzi, la declinazione pittorica fiamminga con echi caravaggeschi è la cifra stilistica di Vera Mercer, e ricorda la fascinazione da microscopio digitale o addirittura la maieutica del Bing Bang lo stigma figurativo di Roberto Pastrovicchio, mentre è una anima contadina esercitata nel proprio orto di casa quella che riconosce a Fabio Rinaldi la possibilità di diventare l’ inizio di un racconto anche a dei ravanelli, chiudendo con l’ allegria e l’ allegoria sociale dei gherigli/cervelli in fuga di Donatella Tandelli.
Ogni cosa edibile diventa un’ occasione di gioco, di ricomposizione semantica e di corti circuiti concettuali curiosi e vitali. Inaspettati. Mondi nuovi costruiti come collage di verdure, di metafisiche bacche di pepe ed imperscrutabili farine, affreschi dal sapore rinascimentale mescolano elementi floreali a plastici crostacei, Bacco e Venere, zucchine e capperi siedono su troni quotidiani, patate gloriose rivendicano vittoriose la propria identità.
E’ un esperimento creativo di intelligenza e garbo questa Mostra. Perché non è un’ abbuffata visiva, quella che propone. Piuttosto una modalità di nutrimento diversa dalle consuete prospettive simboliche, rispettosa di un bene primario certo, ma che rappresenta qualcosa di più. Relazione, cultura, identità, cura, impegno, consapevolezza.
Insomma, un prisma valoriale. Non solo ludico.
Cristina Bonadei
 La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella
La scoperta di un piatto nuovo è più preziosa per il genere umano che la scoperta di una nuova stella